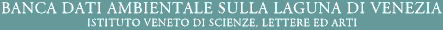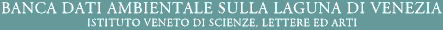Litorali
Introduzione
Sono la zona del lido che si affaccia sul mare. I lidi sono strisce
di terra che separano la laguna dal mare e si estendono per circa 50 Km
dalla foce del Brenta a quella del Sile (da “I
litorali sabbiosi del lungomare veneziano - parte 2ª”,
1980) .
Sono formate da una fascia di alte dune costituite dai depositi alluvionali
dei fiumi, principalmente il Tagliamento e il Piave, modellati in questa
forma parallela alla costa dalla corrente, che nell'Alto Adriatico ha direzione
da nord-est a sud-ovest.
Questa fascia faceva parte della pianura Veneta 6000 anni fa e successivamente,
con l'innalzamento del livello del mare (eustatismo)
e con l'abbassamento del suolo (subsidenza),
ha dato origine ai cordoni litoranei. Il livello dell'antica pianura veneta,
che fino a 18000 anni fa arrivava all’altezza di Pescara (da Cavazzoni
S., “La laguna: origine ed evoluzione”, in “La
laguna di Venezia”, 1996), è costituito dal caranto,
uno strato di argilla mineralizzata molto compatta che costituisce il
fondale naturale della laguna sulla quale i veneziani hanno infitto i
pali che sostengono le costruzioni della città.
La vasta area paludosa che era rimasta confinata alle spalle di tale cordone
inizialmente era una laguna di acqua dolce, ma i periodici sfondamenti
della marea hanno permesso l'ingresso dell'acqua di mare, trasformandola
così in una laguna di acqua salmastra (da “Guida
alla natura nella laguna di Venezia – Itinerari, storia e informazioni
naturalistiche”, 1996).
Tali processi sono tuttora attivi, e i litorali sono continuamente interessati
da fenomeni costruttivi come il deposito di materiale sabbioso proveniente
dal mare (sedimentazione)
e da fenomeni distruttivi quali l'erosione
marina ed eolica.
L'aspetto dei litorali si è modificato nel corso dei secoli non
solamente per la naturale evoluzione di questo ambiente, estremamente
dinamico, ma anche per l'intervento continuo dell'uomo, a causa della
costruzione dei “Murazzi”, dell'estromissione degli affluenti
dalla Laguna, e della realizzazione di dighe foranee e pennelli di protezione.
Interventi umani
Gli interventi dell’uomo sono una costante del suo rapporto
con la laguna, e il loro inizio è coinciso con i primi arrivi in
questo ambiente.
Fino al XV secolo gli interventi si limitarono ad opere di consolidamento
e arginatura di limitate proporzioni, che lasciarono praticamente intatte
le caratteristiche essenziali della laguna originaria.
Le grandi opere che influenzarono e cominciarono a modificare i dinamismi
naturali si sono avute a partire dal XVIII secolo.
I primi interventi si ebbero nel 1738, quando la Repubblica di Venezia realizzò
lungo i litorali di Malamocco, Pellestrina e Sottomarina i Murazzi, opere
di difesa a mare in pietra d'Istria e pozzolana.
Si tratta di dighe frontali il cui obiettivo era di creare una barriera
che impedisse al mare di aggredire ed erodere le rive.
L'idea di realizzare queste difese era stata concepita verso il 1716 dal
padre conventuale Vincenzo Coronelli. Egli inviò ai Savi ed Esecutori
alle Acque il suo progetto innovativo, che prevedeva di sostituire le tradizionali
difese a mare formate da tronchi di quercia e materiali di riporto con una
vera e propria scalinata realizzata con blocchi di pietra d'Istria.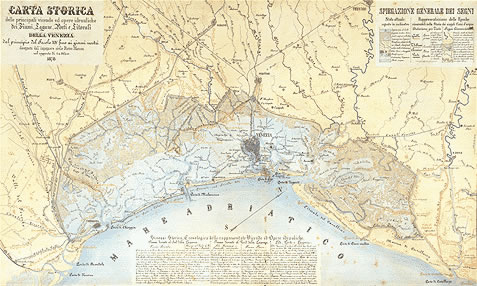
Fu però Bernardino Zendrini, Sovrintendente alle Acque, ai Fiumi
e Laguna a rendere effettivo questo progetto grazie all'introduzione di
un materiale di recente scoperta, la pozzolana, che mescolata alla calce
e messa a contatto con l'acqua si solidifica, consentendo in questo modo
di “saldare” tra loro i blocchi di pietra d'Istria e di rendere
la barriera dei Murazzi ancora più efficace.
Un altro intervento che ha modificato l'aspetto e i dinamismi della laguna
è stato l'estromissione
degli affluenti dalla laguna. La naturale evoluzione dell'ambiente
lagunare prevede il suo interrimento a causa dell'apporto di sedimenti
dagli affluenti, apporto non compensato dall'effetto erosivo delle correnti
marine.
Tale interrimento ha sempre costituito un problema per la Serenissima, perché
avrebbe inciso in modo negativo sulla sicurezza e sulla prosperità
di Venezia, aspetti indissolubilmente legati all'esistenza della laguna
intorno alla città.
Già dal secolo XII vennero eseguiti i primi interventi sui corsi
d'acqua, che vennero arginati in pianura per limitare l'erosione ed il
conseguente trasporto di sedimenti in laguna. L'operazione non ebbe il
risultato sperato, perciò si decise di affrontare il problema radicalmente,
deviando i fiumi che sfociavano in laguna.
Il primo fiume ad essere deviato fu il Brenta, il cui corso fu spostato
da Fusina fino al mare nel 1548. L'interrimento della Laguna in effetti
subì un rallentamento, ma allo stesso tempo aumentò l'erosione
e l’arretramento delle barene, di cui si parla fin dal 1600.
In Laguna è rimasta ancora una traccia ben visibile dell'antico tracciato
del Brenta: il Canal Grande, che è un antico tratto lagunare del
fiume.
Nel 1896 il Brenta fu reimmesso in Laguna, perché il percorso tortuoso
che era costretto a seguire per arrivare fino al mare causava un deflusso
difficoltoso, con conseguenti esondazioni. Ma nei 40 anni successivi l'incremento
del processo di interramento portò alla decisione definitiva di deviare
il fiume a mare, nell'alveo del Bacchiglione.
Il Piave non ha avuto una storia così travagliata come il Brenta:
prima fu deviato a Cortellazzo, poi a S. Margherita, ma nel 1682 esondò
e tornò ad occupare l'alveo che porta a Cortellazzo.
Il Sile, essendo un fiume di risorgiva,
ha sempre presentato pochi problemi di trasporto di sedimenti, e venne deviato
nel 1680 nel vecchio alveo del Piave principalmente per problemi sanitari.
La deviazione a mare degli affluenti ha portato alla scomparsa della fascia
delle paludi, che costituiva un ambiente peculiare e importante per l'avifauna,
e ad un incremento del carattere marino, testimoniato dalla comparsa della
vegetazione alofila e dall'aumento del grado di salinità
delle barene e dei fondali.
Gli ambienti dulciacquicoli attualmente sono ridotti a piccole porzioni
nella fascia di gronda e talvolta sono costituiti da ambienti artificiali
come le cave di argilla abbandonate, trasformatesi successivamente in
aree paludose (es. Cave Gaggio).
Durante il XIX secolo si diffondono inoltre gli interventi sulle valli
da pesca, che vengono arginate con strutture fisse, e alle bocche di porto,
con la costruzione dei moli foranei:
con queste ultime modificazioni viene avviato un processo di sostituzione
degli ambienti lagunari con ambienti di terra. (da Bonometto L., “Le
problematiche naturalistiche nella progettazione e gestione degli interventi
sulla Laguna”, 1997).
Le dighe foranee sono dei moli lunghi centinaia di metri che permettono
il collegamento tra il mare e la Laguna e consentono il flusso e il riflusso
della marea. 
Sono stati costruiti in tre fasi successive a partire dal 1805 alle bocche
di porto di Malamocco, Lido e Chioggia per contrastare la naturale tendenza
all’interrimento dei canali e consentire così l'accesso al
Porto di Venezia a navi di grosso tonnellaggio senza provvedere al continuo
ripristino dei fondali.
Restringendo la sezione del canale, la velocità d'ingresso della
corrente aumenta, aumentando anche la forza erosiva sui fondali, la cui
profondità è passata dai 5 – 6 metri originari fino
ai 20 metri, e talvolta 30, attuali. Questa trasformazione ambientale
ha portato delle variazioni alla naturale circolazione delle acque, provocando
una perdita di materiale sabbioso a valle di ogni diga e un contemporaneo
accumulo a monte delle stesse, come si può facilmente osservare
confrontando i litorali di S. Nicolò al Lido e quello di Punta
Sabbioni al Cavallino.
Evoluzione naturale
Come si può capire da quanto detto finora, l'ambiente litoraneo
è in continua evoluzione sia dal punto di vista morfologico che
funzionale.
Oltre ai mutamenti che sono avvenuti e continuano a manifestarsi su scale
spaziali grandi, è possibile notare anche la continua evoluzione
che contraddistingue l'ambiente del litorale.
La sabbia portata dal vento, ma soprattutto la sostanza organica portata
dalla corrente marina sotto forma di accumuli di alghe
e
fanerogame morte, fanno in modo che il popolamento vegetale
e animale possa evolvere e stabilizzarsi in questo ambiente in apparenza
così inospitale e privo di risorse (da Bonometto L., “Un
ambiente naturale unico – Le spiagge e le dune della penisola del
Cavallino”, 1992).
Ogni “presenza” vegetale e animale crea i presupposti per
l'insediamento di altri organismi, in un processo dinamico di relazioni
strette che si svolge in una fascia limitata che va dalla battigia al
bosco litoraneo.
Gli organismi che vivono in questo ambiente si sono dovuti rassegnare
a condizioni di vita difficili, adottando alcuni stratagemmi che consentono
loro di sopravvivere.
Alcune piante, come l’erba kali (Salsola
kali), cercano di ridurre al massimo le possibili perdite
d'acqua dovute alla traspirazione riducendo la loro superficie fogliare
esposta ai raggi del sole: in questo modo riescono ad accumulare acqua
nei tessuti da utilizzare in caso di siccità (da Bonometto L.,
“Un
ambiente naturale unico – Le spiagge e le dune della penisola del
Cavallino”, 1992).
Inoltre le piante di questo ambiente hanno foglie succulente
che riducono la perdita di acqua per evaporazione, hanno un ciclo vitale
rapido per sfruttare al massimo i periodi più favorevoli ed una
produzione elevata di semi per assicurare l'attecchimento di almeno alcuni
individui (da Bonometto L., “Un
ambiente naturale unico – Le spiagge e le dune della penisola del
Cavallino”, 1992).
Le piante adattate a vivere ad una certa distanza dal mare si raggruppano
in fasce parallele alla linea di battigia, formando associazioni
vegetali le cui caratteristiche rispecchiano la variazioni
delle caratteristiche ambientali dalla battigia agli ambienti più
interni.
Le prime piante che si incontrano allontanandosi dall'acqua del mare sono
piante dette "piante pioniere",
cioè piante che per prime colonizzano un ambiente inospitale preparando
il suolo per le specie più esigenti.
Ed è proprio grazie a queste piante, alla cui base si deposita
la sabbia trasportata dal vento e i materiali portati dalle correnti marine,
che riesce a formarsi la prima fascia delle dune (da Bonometto L., “Un
ambiente naturale unico – Le spiagge e le dune della penisola del
Cavallino”, 1992).
|