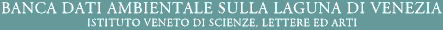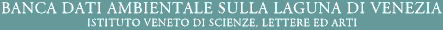Dune
Introduzione
Lungo il litorale veneziano, alle spalle della fascia di spiaggia
vera e propria, si incontrano dei cordoni di dune disposti parallelamente
alla battigia,
intervallati da bassure. Tale ambiente rappresenta una condizione di equilibrio
dinamico tra vegetazione, sedimenti e correnti, sia eoliche che marine.
Le dune del litorale veneto sono formate principalmente da sabbia dolomitica,
proveniente dai detriti trasportati dai fiumi che sfociavano in Laguna:
di conseguenza si è stabilita in questo ambiente un tipo di vegetazione
che predilige i luoghi aridi e ricchi di carbonati di calcio.
L'ammofila (Ammophila
arenaria) è la vera artefice della formazione delle
dune: questa pianta ha una porzione sotterranea molto ramificata e profonda,
che permette di fissarla alla duna e di consolidare la duna stessa (da
"Un ambiente naturale unico – Le spiagge e le dune della penisola
del Cavallino"). L'ammofila tende a venire sepolta dalla sabbia trasportata
dal vento, ma l'emissione di nuovi germogli la fa riemergere: in tal modo
si sviluppa sia la parte aerea, che funge da barriera dove si accumula
la sabbia, sia la parte sotterranea, che costituisce l'ossatura della
duna e determina una prima formazione di humus.
Inoltre possiede delle fogli basali molto sviluppate che formano un cespuglio
denso.
I cordoni dunali smorzano l'azione dei venti proteggendo le zone retrostanti
sia dalla forza del vento che dalla salsedine da esso trasportata.
Le dune embrionali si trovano in prossimità della spiaggia nuda,
sono più basse e sono caratterizzate dalla presenza di piante pioniere
come l'agropiro (Agropyron
junceum) che comincia a trattenere la sabbia trasportata
dal vento. La parte emergente della pianta funge da barriera per la sabbia,
che si accumula alla sua base portando così all'accrescimento verticale
della duna, mentre l'apparato radicale costituisce lo scheletro che dà
stabilità alla duna in formazione.
In questa zona comincia ad aumentare la ricchezza della vegetazione: oltre
all'ammofila infatti si trova la calcatreppola marittima (Eryngium
maritimum), che si è adattata perfettamente all'ambiente
arido grazie alle sua foglie coriacee e spinose e alle lunghe radici che
arrivano ad elevate profondità, l'Echinophora
spinosa, la Silene
sericea.
Il sistema delle dune viene completato dalle dune stabilizzate, che sono
piuttosto elevate e leggermente ondulate. Qui si trova l'ammofila accompagnata
da un'altra specie caratteristica, la Medicago
marina: questa associazione si sviluppa sulle dune che
non sono direttamente esposte ai venti marini, con un microclima caldo
e arido.
Tale ambiente non è omogeneo e presenta due principali sottoambienti:
quello costituito dalle aree più elevate ed asciutte e quello delle
depressioni retrodunali.
Aree elevate
Nelle posizioni più elevate, dove il terreno è più
sciolto e secco perché l'acqua filtra in profondità, l'associazione
vegetale tipica è il Tortuleto-Scabiosetum, chiamata
così perché le specie maggiormente rappresentative sono
la Vedovella (Scabiosa
argentea) e i muschi (spp. Tortula).
Oltre a queste specie troviamo anche equiseti,
funghi,
che sono indicatori della presenza di sostanza
organica in questi ambienti, anche se scarsa, e i licheni,
che in questo ambiente vivono sul terreno e appartengono alla specie Cladonia.
Questa associazione succede agli ammofileti sulle dune più vecchie,
e necessita di più di 100 anni per formarsi in maniera completa.
Depressioni retrodunali
Nelle depressioni il terreno è più ricco di carbonati e
di limo, dilavati dalle dune soprastanti: qui l'acqua spesso ristagna,
permettendo così la crescita a giunchi (es:
giunco nero) e altre piante palustri, dando vita all'associazione
vegetale tipica di ambiente umido (Schoeneti) ("Un ambiente naturale
unico – Le spiagge e le dune della penisola del Cavallino").
Questa aree acquitrinose sono state in gran parte bonificate per interramento,
provocandone la regressione e il rischio di estinzione.
Alcuni mammiferi frequentano l'ambiente delle dune, come il riccio (Erinaceus
europaeus) e il topo selvatico (Apodemus
sylvaticus) ("Guida alla natura nella laguna di Venezia
– Itinerari, storia e informazioni naturalistiche").
Successione vegetale
La successione delle serie vegetali della duna, partendo dalla battigia,
è quindi la seguente:
Cakiletum – Agropyretum – Ammophiletum – Tortulo-Scabiosetum
– Schoenetum ("Un ambiente naturale unico – Le spiagge
e le dune della penisola del Cavallino").
Nella maggior parte delle spiagge del litorale veneziano la successione
della vegetazione di duna si interrompe al Tortuleto – Scabiosetum,
al massimo si può rilevare la presenza dello Schoenetum: solamente
sulle spiagge di più antica formazione, come il Bosco Nordio, è
possibile osservare un ulteriore stadio di evoluzione che porta alla formazione
di un vero e proprio bosco caratterizzato dalla presenza del leccio (Quercus
ilex).
Evoluzione delle
dune
L'evoluzione delle dune è strettamente legata all'azione dell'uomo:
in assenza di disturbo la duna tende a consolidarsi sempre più,
rompendo il vento che proviene dal mare e facendo quindi accumulare la
sabbia nelle zone antistanti la duna stessa.
Con il tempo questo processo permette alla spiaggia di avanzare verso
il mare e di formare nuove dune che verranno a loro volta colonizzate
dalle piante.
Purtroppo il calpestio, frequente soprattutto nei mesi estivi, causa la
modifica delle dune, in quanto distrugge l'apparato radicale delle piante,
che non riescono più a trattenere efficacemente la sabbia: questa
viene trasportata negli ambienti retrodunali e nei boschi sempreverdi,
che ne vengono danneggiati.
Piante e sabbia sono quindi tra loro complementari: se viene eliminata
la sabbia la pianta muore e se le piante vengono rimosse la sabbia viene
trasportata in altri luoghi.
I sistemi dunosi che sono sopravvissuti quasi intatti all'azione umana
sono presenti a Ca' Roman e agli Alberoni.
Funzione della
vegetazione dunale
La funzione della vegetazione non si limita al consolidamento della duna
e alla protezione degli ambienti retrostanti: offre anche un habitat
ottimale per alcuni organismi. Gli ambienti antistanti la duna sono caratterizzati
da assenza di vegetazione e di conseguenza da una insolazione costante
che determina una temperatura elevata della sabbia. I cespugli di ammofila
sono le prime piante sufficientemente alte da creare un cono d'ombra al
loro interno, dove si ritrova un microclima
umido e fresco che offre riparo diurno per gli invertebrati
che popolano la spiaggia. Per verificare i benefici della presenza di
questa graminacea,
è sufficiente toccare la sabbia all'interno del cespuglio: si avvertirà
una sensazione di fresco, anche perché le radici per capillarità
consentono la risalita di acqua dal sottosuolo, mantenendo così
costantemente umido il terreno.
Anche in questo caso la struttura degli organismi è finalizzata
alla vita nell'ambiente: si trova qui un piccolo coleottero, il Leichenum
pictum, che si mimetizza perfettamente con la sabbia, della
quale riproduce addirittura il disegno dei granelli, o lo scarabeo (Scarabaeus
semipunctatus) le cui zampe posteriori sono provviste
di robuste setole disposte a pettine che consentono di spostarsi agevolmente
sulla sabbia.
Nella sabbia si trova la larva del formicaleone (Myrmeleon
formicarius), che scava dei piccoli avvallamenti a forma di imbuto
utilizzati come trappola per i piccoli insetti che vi scivolano dentro,
e dei quali il formicaleone si nutre. Vive in prossimità dei cespugli
di ammofila perché qui è maggiore la possibilità
di trovare delle prede, attirate dal microclima favorevole.
A conferma del progressivo aumento del carattere terrestre degli ambienti
man mano che si procede verso l'interno del litorale, troviamo nella zona
delle dune il primo mollusco terrestre, una piccola chiocciola che vive
sulle erbe (Theba
pisana) e che è tipica degli ambienti caldi e secchi
("Un ambiente naturale unico – Le spiagge e le dune della penisola
del Cavallino").
|