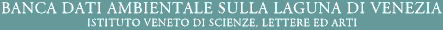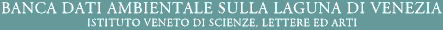Ambiente
urbano
Fauna di città
Molti animali hanno trovato nella città di Venezia un luogo ospitale
dove vivere, e i motivi che li hanno spinti a questa scelta possono essere
i seguenti:
-
in città gli animali trovano
quegli anfratti e quelle nicchie che mancano nell’ambiente naturale 
circostante: oltre ai pipistrelli, ecco che i rondoni ( Apus
apus), i piccioni ( Columbia
livia), gli storni ( Sturnus
vulgaris) e altri uccelli trovano rifugio nei solai,
tra le tegole dei tetti, nelle crepe delle case; -
-
alcuni animali hanno trovato nei
rifiuti dell’uomo una grande risorsa di cibo: sono note a tutti
le razzie fatte dai gabbiani (gabbiano reale – Larus
cachinnans -, gabbiano comune - Larus
ridibundus) e dai ratti delle chiaviche ( Rattus
norvegicus); -
la città di Venezia si trova
al centro di una laguna che è una delle più importanti
aree umide d’Europa, per il numero di specie e di individui
di uccelli svernanti,
nidificanti
e stanziali
che ospita. È inevitabile quindi che anche la città
stessa sia soggetta al passaggio e alla sosta di alcuni volatili.
Flora di città
Quando si pensa alla flora
di città, soprattutto di una città come Venezia,
vengono in mente i giardini pubblici o quelli privati, splendidi angoli
di verde nascosti all’interno delle corti.
Ma c’è un mondo più piccolo e meno nascosto, che
si svela agli occhi più attenti ed osservatori, che popola le
rive, le fondamenta e i muri della città.
Sui muri delle rive, nella fascia degli spruzzi ancora influenzata dalla
presenza dell’acqua salmastra del canale, si trovano specie adattate
agli ambienti salsi, come il Finocchio di mare (Crithmum
maritimum), il Limonio comune (Limonium
vulgaris) e l’atriplice comune (Atriplex
hastata).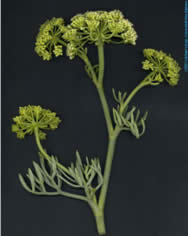
Risalendo la riva, si giunge al bordo della fondamenta: qui
il disturbo antropico dovuto al calpestio è ridotto, data la
sua vicinanza al bordo del canale, e le piante che vi crescono riescono
a raggiungere dimensioni maggiori. Inoltre viene meno l’influsso
dell’acqua salsa del canale, mentre aumenta la quantità
di sostanza
organica, accumulata nelle fessure presenti tra una pietra
e l’altra. In questa zona si trovano l’amaranto (Amaranthus
retroflexus), il farinaccio bianco (Chenopodium
album), la gramigna (Cynodon
dactylon), il dente di leone (Taraxacum
officinale).
Proseguendo verso l’interno della fondamenta, il disturbo da calpestio
aumenta e sia le specie sia il portamento delle piante cambiano. Qui
si trovano piante dalle dimensioni minori, solitamente appressate al
suolo, con foglie e fiori piccoli, che riescono a sopravvivere al calpestio
rifugiandosi all’interno delle fessure tra un pietra e l’altra.
Di questa comunità fanno parte la piantaggine (Plantago
maior), la burinella (Sagina
procumbens) e la corregiola (Poligonum
aviculare).
Lungo i muri o ai lati dei gradini dei ponti, dove il grado di calpestio
è minimo e si accumula del terriccio, si sviluppa un altro tipo
di vegetazione. Si trova la saeppola (Conyza
canadensis), la borsa del pastore (Capsella
bursa – pastoris), il crescione dei prati (Cardamine
hirsuta), l’orzo selvatico (Hordeum
murinum), la fienarola annuale (Poa
annua), l’erba cardellina (Senecio
vulgaris), la porcellana (Portulaca
oleracea), la verbena (Verbena
officinalis).
Altre piante non devono affrontare il problema del calpestio, in quanto
crescono sui muri delle case e sulle arcate dei ponti. La più
comune è la parietaria (Parietaria
officinalis), seguita dall’ederina dei muri (Cymbalaria
muralis). I primi organismi a colonizzare le pareti
degli edifici e dei ponti sono i licheni,
che sono in grado di sgretolare la roccia e di preparare il terreno
per altre piante più esigenti.
Le piante che si trovano in città hanno metodi diversi per riuscire
a superare l’inverno: in alcune (Emicriptofite)
le foglie continuano a vegetare sotto forma di rosetta
basale, che essendo appressata al suolo sfrutta il calore
proveniente da esso ed è protetta dalle foglie morte della stessa
pianta. Altre invece (Terofite)
svernano sotto forma di semi, che germinano solamente quando le condizioni
diventano favorevoli.
La disseminazione
è resa efficiente sia dall’elevata quantità di semi,
che assicura maggiori probabilità di una buona riuscita, sia
dalla tipologia di semi, che spesso sono dotati di un pappo
o sono comunque molto leggeri, strategie che permettono loro di raggiungere
ambienti favorevoli anche se si trovano ad una grande distanza dalla
pianta madre.
Canali
di Venezia
Per scoprire una tipologia particolare di flora
e fauna
della laguna di Venezia, non sempre è necessario andare alla ricerca
di ambienti speciali, ma è sufficiente guardare con più
attenzione lungo le sponde dei canali che attraversano la città.
Una grande varietà di organismi sia animali che vegetali popola
le sponde, sia sopra che sotto il livello dell’acqua.
Per l’osservazione il periodo migliore è la primavera, quando
l’attività biologica degli organismi raggiunge i livelli
massimi, e in particolar modo durante le fasi di bassa marea,
quando la fascia visibile è più estesa.
L’ambiente di riva dei canali veneziani può essere suddiviso
in tre fasce facilmente distinguibili:
La
fascia degli spruzzi
Questa fascia è raggiunta dagli spruzzi, e solo occasionalmente
è interessata dalle maree eccezionali.
La sua ampiezza varia a seconda dell’intensità del moto
ondoso, da 50 a 100 centimetri.
E’ popolata da organismi altamente specializzati: infatti gli organismi
terrestri presenti devono essere in grado di sopportare la salinità
e le periodiche sommersioni, mentre al contrario quelli marini devono
essere capaci di resistere durante i lunghi periodi di emersione.
Sulla parte superiore dei muri che costeggiano i canali, ma anche sui
gradini delle porte d’acqua dei palazzi, si può osservare
una patina verde, formata da alghe
verdi microscopiche (Cloroficee), che indicano l’altezza massima
alla quale arrivano gli spruzzi.
I primi organismi animali che si trovano in questa zona sono dei Crostacei
Isopodi a respirazione aerea: la ligia (Ligia
italica) e il Tylos. Entrambi sono molto simili ai porcellini
di terra, ma la ligia è distinguibile per la velocità con
la quale si ritrae all’arrivo dell’onda.
Nella zona di transizione tra la fascia degli spruzzi e quella sottostante vivono
le littorine (Littorina
littorea), che sono dei Molluschi Gasteropodi.
Queste chiocciole vivono su substrati maggiormente meno friabili dei mattoni,
e quindi per lo più su pietre che offrono una buona adesione e
una presenza costante di alghe, delle quali si cibano.
di transizione tra la fascia degli spruzzi e quella sottostante vivono
le littorine (Littorina
littorea), che sono dei Molluschi Gasteropodi.
Queste chiocciole vivono su substrati maggiormente meno friabili dei mattoni,
e quindi per lo più su pietre che offrono una buona adesione e
una presenza costante di alghe, delle quali si cibano.
Vivono in piccoli gruppi nella zona che è regolarmente sommersa
durante l’alta marea, e quindi sono osservabili con la bassa e media
marea. Nel periodo invernale si rifugiano in fessure strette non raggiunte
dall’acqua, e nonostante siano una specie marina riescono a resistere
ad emersioni relativamente lunghe.
In questa zona si trova l’enteromorfa (Enteromorpha
intestinalis), che si adatta alle difficili condizioni
dettate dalle periodiche emersioni riducendo al minimo il suo sviluppo.
Zona
dell’escursione di marea
Questa fascia, chiamata anche zona intertidale, a Venezia ha lo spessore
di circa 1 metro.
Vi si trovano Crostacei
che aderiscono direttamente al substrato e che si trovano anche sui pali
conficcati nel caranto, addossati gli uni agli altri.
I balani sono dei Crostacei Cirripedi, dotati cioè di arti che
vengono utilizzati per creare dei piccoli vortici d’acqua per convogliare
il cibo verso la loro bocca. Non assomigliano agli altri cirripedi, in
quanto l’adattamento alla vita sedentaria ha determinato in loro
notevoli mutamenti, e solo nella fase giovanile si possono rinvenire mentre
nuotano liberamente.
Le specie più abbondanti e caratteristiche che si trovano lungo
i canali di Venezia sono la capa de palo (Balanus
amphitrite) e il dente de can (Chthamalus
stellatus).
Spesso si ritrovano anche attaccate alle valve
delle cozze.
Riescono a sopportare le periodiche emersioni grazie a due placchette
mobili collocate sulla sommità del loro corpo, che permettono il
contatto con l’esterno quando sono sommersi, e di isolarsi mantenendo
al loro interno le condizioni dell’ambiente acquatico circostante
durante le emersioni.
Accanto ai Balani si trovano le Patelle
(Patella
coerulea), Molluschi Gasteropodi.
La loro conchiglia si adatta perfettamente al substrato sul quale si trova
grazie al suo piede
muscoloso, aderendovi perfettamente, e tale strategia ha un duplice obiettivo:
difendersi dalle possibile aggressioni e trattenere una riserva di acqua
marina all’interno del guscio nei periodi di emersione.
In questo ambiente le alghe
trovano situazioni più adatte per il loro sviluppo, e il numero
di specie diverse aumenta.
L’Enteromorfa
raggiunge il massimo del suo sviluppo vegetativo e compaiono anche la
Porfira (Porphyra
leucosticta), il Ceramio (Ceramium
rubrum), e la Lattuga di Mare (Ulva
lactuca).
L'Enteromorfa e la Lattuga di Mare sono alghe verdi, mentre la Porfira
e il Ceramio sono alghe rosse, la cui presenza è giustificata dal
fatto che l’acqua dei canali di Venezia è molto torbida e
non permette alla lunghezza
d’onda del verde di penetrare, mentre la banda del rosso
riesce ad attraversare la colonna d’acqua senza subire notevoli
assorbimenti.
Tra queste alghe
si trovano i Crostacei,
come il Granchio Verde, le cui femmine sono le cosiddette masanete.
Questi Decapodi
si trovano nei canali soprattutto in primavera, quando si spostano
dal mare alla laguna, e in autunno, quando compiono il percorso opposto.
Durante l’accrescimento il granchio abbandona il carapace
diventato piccolo, e durante la fase di muta
il suo corpo è molle e privo di difese: questa fase dura qualche
ora, durante la quale il granchio viene indicato con il termine di moeca.
Zona
di bassa marea
Oltre alle alghe,
ai Molluschi e ai Crostacei
compaiono anche i peoci, le cozze (Mytilus
galloprovincialis) che si attaccano al substrato sul quale
vivono tramite il bisso,
formato da filamenti prodotti da una ghiandola (ghiandola del bisso) che
si solidificano a contatto con l’acqua.
Nelle zone dove l’emersione è più frequente le dimensioni
delle cozze
sono minori perché più brevi sono i periodi durante i quali
i mitili
riescono a nutrirsi di piccole alghe e particelle di materiale organico
presenti nell’acqua.
La cozza è un organismo sessile,
cioè vive attaccato ad un substrato, ma se si trova in un ambiente
dove le condizioni di vita sono estremamente sfavorevoli, possiede la
capacità di staccarsi e di farsi trasportare dalla corrente galleggiando
grazie a delle bolle di gas emesse dall’interno della conchiglia.
Le loro valve
non sono molto resistenti, perciò la principale strategia di sopravvivenza
consiste nel formare banchi fittissimi, nei quali i loro margini affilati,
tutti rivolti verso l’esterno, costituiscono un tappeto solido e
difficilmente penetrabile (da Bonometto L., Mizzan L., “Forme
& significati – Osservazioni e riflessioni sugli animali del
nostro mare”, Quaderni del Museo Civico di Storia
Naturale di Venezia, Supplemento al Vol. XXXVIII del Bollettino del Museo
Civico di Storia Naturale di Venezia, 1987).
Durante la bassa marea è possibile osservare anche Botrilli,
Ascidie, Spugne, Attinie.
Altre specie tipiche di questo ambiente non sono sessili e hanno la possibilità
di spostarsi per ricercare delle condizioni maggiormente favorevoli (da
Pellizzato M., Carlotti G., “L’ambiente di riva dei canali
di Venezia”, in
“Lavori” della Soc. Ven. Sc. Nat., vol. 5, supplemento ad
uso didattico, 1981).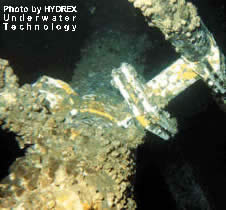
I canali di Venezia offrono anche un ambiente ideale nel quale studiare
il fenomeno del fouling,
che è un fenomeno di incrostazione sugli oggetti sommersi realizzato
da organismi marini. Osservando infatti un palo o una qualche altra struttura
artificiale introdotta nel canale, è interessante notare come la
colonizzazione di questo nuovo ambiente segua una successione
ben precisa, e facilmente riscontrabile in qualsiasi altro substrato immesso
con le medesime modalità.
I primi organismi sono le alghe, che non necessitano di un particolare
substrato su cui insediarsi, dato che traggono il loro nutrimento direttamente
dalla loro superficie tallosa, essendo privi di radici. Le alghe quindi
costituiscono il fouling primario.
Su di loro successivamente si insediano i mitili, il cosiddetto fouling
secondario, mentre i balani sono indifferenti al grado di colonizzazione
del substrato, e possono appartenere sia al fouling primario che a quello
secondario (da Cornello M.,
“Contributo
allo studio ecologico delle comunità bentoniche sessili nella Laguna
di Venezia: struttura e dinamica in relazione ai periodi d'insediamento"
- tesi di laurea, A.A. 1994-95, Università degli Studi di Padova).
Il quadro delineato è tipico dell’ambiente di canale, ma
viene notevolmente influenzato dall’inquinamento
che, soprattutto nei canali con minore ricambio idrico, causa una drastica
riduzione delle specie presenti, lasciando campo libero alle specie più
resistenti.
|